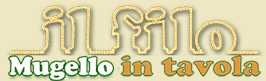Dicomano, città medievale aperta

DICOMANO – Dicomano, per la sua posizione geografica, ha sempre rappresentato un punto privilegiato, non solo dal punto di vista strategico, ma anche per gli scambi commerciali tra Romagna, Mugello e Casentino. E questo non è un mistero, tanto che già Etruschi e Romani utilizzarono a tale scopo l’abitato, o quel poco che c’era allora di costruito intorno ai guadi di Sieve e Comano. Fin dall’Alto Medioevo sappiamo che il paese fu al centro dei commerci e un frequentato mercato vi si teneva almeno fin dall’inizio del Duecento. Non mancavano neppure i pedaggi stradali di cui restano ampie tracce; tanto per fare un esempio, uno riguardava proprio la strada di Dicomano “per terram et flumina” ed era pari a 40 fiorini pagati da un certo Ugo a Giovanni di Cino da Dicomano (1335). Quest’ultimo era un personaggio piazzato lì dal notaio Giovanni di Buto, il famoso “visconte” di Ampinana, sul quale ho scritto un libro, forse il più famoso personaggio storico della zona.
Prima di aprire in paese una florida attività commerciale in stoffe, Giovanni eseguì diversi atti notarili a Dicomano; curiosamente quelli che riguardavano Curia e contea di Ampinana li firmava quasi tutti nella Pieve di Santa Maria, quelli per i conti Guidi della Contea del Pozzo, nello Spedale del Forese, e quelli ordinari durante i mercati settimanali, quasi fosse intervenuto in paese un tacito accordo di spartizione e convivenza tra potere feudale, comunale ed ecclesiastico.
Questi poteri erano ben presenti in paese ormai da vecchia data, se si considera che già nel 1010 era stato concesso dai Guidi il nucleo primitivo di Dicomano al Vescovo in “feudo oblato” e che la “corte di Valfonda” viene ricordata già nel 1103 tra i beni del vescovado fiorentino. Di antica datazione fu anche l’insediamento dei Guidi sui castelli circostanti; per maggiori informazioni su quest’argomento consiglio il bel libro “Castelli e strutture fortificate nel territorio di Dicomano in età medievale” redatto su iniziativa del Gruppo Archeologico dicomanese. Sicuramente Dicomano fu comunque una “città aperta” dove la vicinanza tra le contee del Pozzo e di Ampinana, forte potere vescovile e presenza invadente in ambito commerciale del Comune fiorentino, non costituì mai occasione di scontro, piuttosto opportunità multiple di affari vantaggiosi e redditizi per tutte le parti in causa.
Dunque, non può nemmeno lasciarci stupiti che esistessero ben tre mercati nell’esiguo triangolo territoriale ricompreso tra Dicomano/Londa, Pavanico e San Godenzo e ancor più sorprendente e sconcertante è scoprire che nella stessa zona esistevano diversi sistemi di misurazione e pesatura tra piccoli paesi contigui. Nella zona est del Mugello erano almeno otto, perché ad esempio Corella adottava la sua misura mentre a Belforte e Orzale di Ampinana ne esisteva una diversa, tanto per non confondersi con i “vicini”! Eppure, erano territori che dipendevano tutti dai Guidi di Belforte.
Proseguendo, se Dicomano aveva il suo staio (Starium fori), un sistema di peso differente aveva la vicina Pavanico nella curia di Orzale (staio fori Pavanici), nucleo economico della contea di Ampinana. Il fatto sembrava quasi voler rimarcare orgogliosamente le residue differenze amministrative esistenti tra l’antico mercato feudale, che era stato condannato all’isolamento e all’oblio, e quello comunale. Sistemi di misurazione diversi in staia si trovavano pure a San Godenzo, Borgo dell’Isola e San Bavello.

I mercati erano talmente ben organizzati con la presenza di notai che venivano registrati persino i frequentatori; in questo modo possiamo ad esempio sapere che a un mercato d’inizio Trecento tenuto nel forum di Pavanico parteciparono ben 328 persone mentre a Dicomano, cui era profondamente collegata la contea di Belforte, nello stesso periodo in un altro mercato furono 790. E se ne conosce persino la provenienza; venivano da Cistio, Sagginale, Ampinana, Corella, Casaromana, Bovino e casolari sparsi dei dintorni. Dai registri notarili del decennio 1320-1330 si scopre anche che le aree di gravitazione della popolazione rispetto ai mercati erano abbastanza esclusive. In parole povere, difficilmente chi si trovava in una zona sceglieva di andare in un mercato più lontano; nella maggior parte dei casi si trattava di persone che abitavano nelle immediate vicinanze, anche per un problema logistico di trasporto della merce eventualmente acquistata.
In quest’animato contesto sono di sicuro importanti alcuni ritrovamenti di monete e tessere mercantili a Pavanico e Vicorati, dove si svolgevano questi piccoli raduni e che confermano la presenza in loco di mercati attivi. Le tessere mercantili, che secondo studi recenti erano una specie di “gettoni di conto”; venivano probabilmente utilizzate per ottenere l’esenzione dal dazio di dogana o un riconoscimento per il ritiro di balle di mercanzia nei depositi. Difatti, essendo i mercatali collocati in territorio fiorentino, sulle merci era applicata una tassa. A tale proposito, assai curioso appare un fatto accaduto a Dicomano il 17 Luglio 1367 quando un certo Gianus Calamai della Villa di Dicomano portò alcune bestie al macello in una zona fuori del contado fiorentino. Il motivo? Un tentativo per evadere appunto l’odiata… tassa di dogana! Passano i secoli, ma l’evasione fiscale era e rimane un vizio diffuso in tutte le epoche!
Fabrizio Scheggi
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 1 Marzo 2025